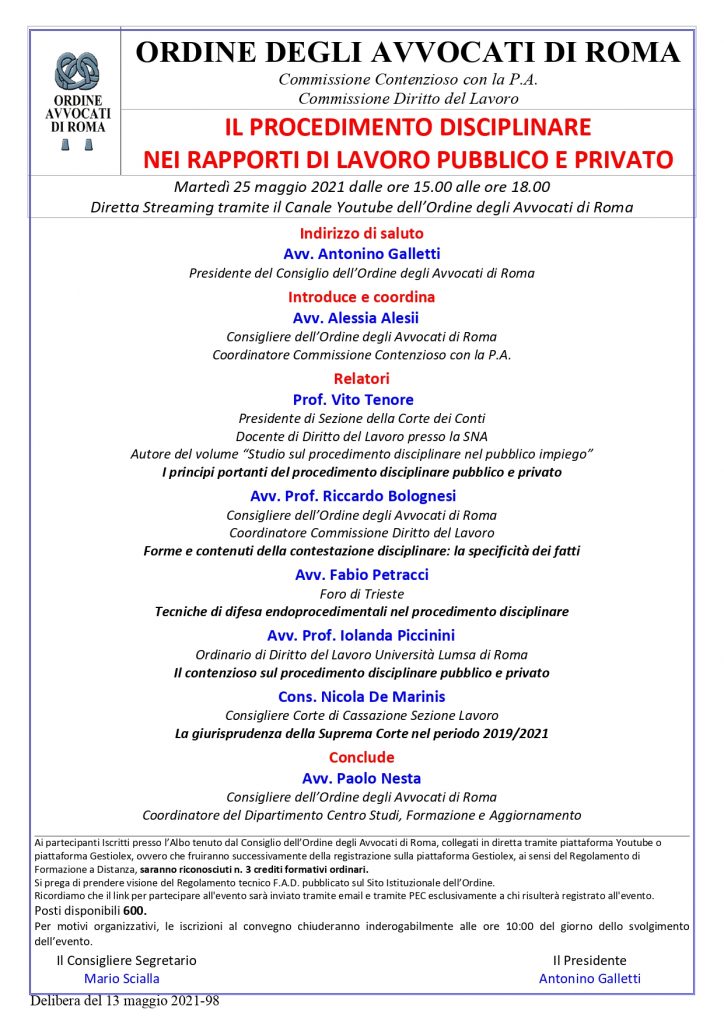Legge 104 – abuso e
licenziamento.
La Corte
di Cassazione è stata investita di un caso dove un lavoratore dopo aver
dichiarato che la persona assistita non era ricoverata a tempo pieno, fruisce
di tutta una serie di permessi giornalieri.
Il datore
di lavoro scopre che la persona da questi assistita è in realtà ospitata presso
una struttura assistenziale di natura alberghiera e non ospedaliera. A causa
della dichiarazione mendace, il lavoratore viene licenziato. Impugna il
licenziamento. Il suo ricorso è respinto in tutti i gradi di giudizio, sino a
quando la cassazione ribalta il verdetto ritenendo che l’ospitalità presso una
struttura alberghiera non equivale al ricovero che, secondo la Cassazione, deve
intendersi quale ricovero ospedaliero.
Va
ricordato come la legge 183/2010 abbia modificato il testo della legge 104/1992
inserendo all’articolo 33 comma 3 la specifica condizione che per la
concessione dei permessi la persona assistita non doveva essere ricoverata a
tempo pieno.
La
Cassazione ha ritenuto che per ricovero debba intendersi esclusivamente il
ricovero ospedaliero.
Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent.14-08-2019, n. 21416
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26136-2017 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
MARATONA N. 87, presso lo studio dell’avvocato SABINA COLLETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MAGRINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA ZUCCA;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 762/2017
della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/09/2017 R.G.N. 546/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA;
udito l’Avvocato CHIARA MAGRINI.
Svolgimento
del processo
1. Con ricorso L. n. 92 del 2014, ex art. 1, comma 47,
al Tribunale di Torino R.G., dipendente della ASL TO5 in qualità di operatore
tecnico autista, impugnava il licenziamento per giusta causa comminatogli con
Delib. Direttore Generale 25 luglio 2016, n. 370 per avere il predetto, in sede
di dichiarazione resa in data 10 luglio 2014, dichiarato che il soggetto
disabile per il quale beneficiava dei permessi ai sensi della L. n. 104 del
1992, art. 33, comma 3,
non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura.
2. Il Tribunale, in esito alla fase sommaria,
respingeva la domanda.
3. La decisione era confermata in sede di opposizione.
4. Il reclamo proposto dal R. era respinto dalla Corte
d’appello di Torino.
La Corte territoriale, per quel che qui interessa,
precisava che: a) il dipendente con l’indicata dichiarazione – sottoscritta
nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà D.P.R. n. 445
del 2000, ex art. 47 e ss. – aveva affermato che la madre, in
relazione alla quale usufruiva dei benefici della L. n. 104 del
1992, art. 33 non
era “ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura”, mentre la
ASL, a seguito di controlli, aveva appurato che già da due anni la signora
soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera; b) in sede
disciplinare era stata contestata unicamente la dichiarazione falsa resa alla
datrice di lavoro, senza indagare se sussistessero le condizioni per la
fruizione dei suddetti benefici, ciò, però, muovendo dalla premessa che tali
benefici comportano notevoli oneri economici e organizzativi e trovano la loro
giustificazione solo nella effettiva tutela delle persone disabili; c) quanto
all’elemento soggettivo, doveva essere evidenziata la diversità dei criteri e
dei presupposti dell’accertamento della responsabilità, rispettivamente in sede
penale e in sede disciplinare, sicchè, a prescindere dall’avvenuta
archiviazione del procedimento penale, nella sede deputata all’accertamento
della responsabilità disciplinare la dichiarazione mendace contestata andava
considerata frutto di dolo o, almeno, di grave negligenza; d) l’illecito era da
reputarsi di tale gravità da meritare la massima sanzione espulsiva tenendo
conto del fatto che la dichiarazione falsa era stata resa nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da un soggetto legato da un vincolo
fiduciario con il datore di lavoro destinatario.
2. Avverso tale decisione R.G. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi.
3. La ASL (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
4. In seguito a rinvio a nuovo ruolo la discussione
della causa è stata nuovamente fissata per l’odierna udienza.
5. Entrambe le parti hanno depositano memoria ex art. 378
c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del
1992, art. 33, commi 3,
4 e 7-bis, sostenendosi che la Corte d’appello avrebbe
confermato il licenziamento del ricorrente sulla base di un fatto inesistente
rappresentato dall’illegittima fruizione dei permessi di cui al richiamato art.
33.
2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in
relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 55-bis nonchè
dell’art. 29, comma 2 c.c.n.l. 1 settembre 1995; b) in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c., rilevandosi che la questione dell’illegittima fruizione dei
permessi citati non avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Corte
d’appello, visto che non era stata contestata e neppure introdotta in giudizio
dalla datrice di lavoro, sicchè la sentenza impugnata sarebbe anche affetta dal
vizio di ultrapetizione.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del
1992, art. 33, commi 3,
4 e 7-bis, dell’art.
2106 c.c. nonchè degli artt. 28 e 29, comma 1, del c.c.n.l. 1
settembre 1995, perchè la Corte territoriale, violando le norme richiamate e i
principi generali della materia, avrebbe confermato il licenziamento sulla base
di un comportamento privo di qualunque illiceità, visto che in sede penale il
procedimento a carico del R. era stato archiviato in quanto era stata esclusa
l’ascrivibilità di una falsa dichiarazione o reticenza essendosi ritenuto che
il termine ‘ricoverò nell’ambito del citato art. 33 fosse da riferire soltanto
alle strutture di tipo sanitario e non a quelle di tipo alberghiero come quella
in cui si trovava la madre dell’interessato.
In questa situazione, non essendo compresa la condotta
contestata neppure tra quelle indicate dal c.c.n.l. come meritevole di sanzione
disciplinare, la Corte d’appello avrebbe, in definitiva, considerato meritevole
del licenziamento un comportamento privo di illiceità, muovendo da una erronea
accezione del termine ricovero, come se fosse da riferire anche al soggiorno in
strutture residenziali.
4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del
2010, art. 30, comma 3,
dell’art. 13 del c.c.n.l. 19 aprile 2004, dell’art. 29, comma 9, del c.c.n.l. 1
settembre 1995, in via subordinata si deduce che la Corte d’appello non si
sarebbe attenuta ai criteri legislativi e contrattuali sulla proporzionalità
tra infrazione e sanzione, avendo del tutto ignorato al riguardo le previsioni
del c.c.n.l. che indicano le ipotesi in cui è applicabile il licenziamento
senza preavviso.
5. Va preliminarmente respinta l’eccezione di
improcedibilità del ricorso formulata dall’Azienda controricorrente per non
avere il R. prodotto l’integrale testo del c.c.n.l. in relazione al quale ha
formulato parte delle censure.
Questa Corte ha da tempo affermato che
l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369
c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del
contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della
controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle
relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento
formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile
della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di
conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 47, comma 8,
sì che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40
del 2006 (che all’art. 7 ha apportato modifiche all’art. 369
c.p.c. prevedendo che il comma 2, n. 4 di tale articolo è
sostituito dal seguente: “4. Gli atti processuali, i documenti, i
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”), deve
essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (Cass., Sez. Un., 12
ottobre 2009, n. 21558; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009, n. 23329; Cass. 11
aprile 2011, n. 23329).
6. Tanto precisato, il ricorso, nei motivi in cui è
articolato, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, è
fondato per le ragioni di seguito illustrate.
7. Ai fini di un ordinato iter motivazionale occorre,
preliminarmente, ricostruire la ratio legis dell’istituto del permesso mensile
retribuito di cui alla L. 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 3,
alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno
caratterizzato.
7.1. In termini generali può dirsi che la norma ha
individuato le condizioni cui è subordinato il godimento del diritto e i
soggetti che ne sono titolari.
Si tratta di una misura a sostegno dei disabili il cui
presupposto è costituito dall’esistenza dello stato di handicap grave della
persona da assistere, accertato dagli organi competenti e tale da richiedere un
intervento assistenziale permanente e continuativo (ai sensi della L. n. 104 del
1992, art. 3:
“1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali”).
7.3. La normativa specifica in tema di permessi per
l’assistenza a familiari disabili di cui alla indicata L. n. 104 del
1992, è la risultante dell’intreccio di diverse disposizioni, che
sono state modificate in più occasioni nel corso del tempo. In particolare,
l’art. 33, comma 3 di tale legge, nella sua originaria formulazione, così
disponeva: “3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.
7.4. La disposizione è stata modificata una prima
volta con la L. 8 marzo
2000, n. 53 che, all’art. 19, comma 1, lett. a), ha previsto la
copertura da contribuzione figurativa dei giorni di permesso retribuito di cui
al comma 3 cit. art. e, all’art. 20, ha sancito l’applicabilità delle
disposizioni della L. n. 104 del
1992, art. 33 “ai
genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente”.
7.5. Dalla lettura congiunta della L. n. 104 del
1992, art. 33 con
la L. n. 53 del
2000, art. 20 la
prevalente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato,
sezione quarta, 22 maggio 2012, n. 2964; Consiglio di Stato, sezione sesta, 1
dicembre 2010, n. 8382) ha desunto la eliminazione del requisito della
convivenza anche per i permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3
nonchè l’introduzione dei diversi requisiti della continuità ed esclusività
dell’assistenza ai fini della concessione delle agevolazioni in questione.
7.6. La disposizione normativa è stata oggetto di
ulteriore modifica ad opera della L. 4 novembre
2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) che, all’art. 24, ha
sostituito il comma 3 con il seguente: “3. A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente”.
7.7. La Legge del 2010 ha, inoltre, con l’art. 23,
delegato il Governo a riordinare l’intera materia relativa a congedi,
aspettative e permessi, al fine di realizzare un “coordinamento formale e
sostanziale” delle prescrizioni in vigore (comma 2, lett. a).
7.8. E’ stata apertamente dichiarata la necessità di
“garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e… adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo” (lett.
a); al contempo, si è sottolineata l’esigenza di risistematizzare le tipologie
dei permessi, con la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti
soggettivi (lett. c e d), semplificando gli oneri di allegazione della
documentazione richiesta (lett. e).
In particolare, il legislatore, nel ridefinire la
categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere
persone in situazione di handicap grave, ha ristretto la platea dei
beneficiari.
Infatti, se, da un lato, ha eliminato la limitazione
del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso
mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in
situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica,
fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli
portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, ha
riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al
lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Solo in casi particolari l’agevolazione in questione
può essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da
assistere.
Infatti, l’estensione del diritto a fruire dei
benefici in questione ai parenti e affini di terzo grado è stata prevista nei
casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità:
a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; b) siano affetti da patologie
invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.
7.9. Il citato L. n. 183 del
2010, art. 24 se,
dunque, da un lato, ha eliminato i requisiti della continuità ed esclusività
dell’assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, dall’altro, nel
modificare della L. n. 104 del
1992, l’art. 33, comma 3, ha introdotto il principio del referente
unico per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile
retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i
genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l’assistenza dello
stesso figlio affetto da grave disabilità. Nella formulazione dell’art. 33,
comma 3, come sostituito dalla L. n. 183 del
2010, art. 24, comma 1,
lett. a), è stato, peraltro, espunto espressamente il requisito
della convivenza.
7.10. Il legislatore è intervenuto nuovamente nella
materia dei permessi mensili retribuiti spettanti per l’assistenza a persone
con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nella L. n. 183 del
2010, art. 23.
Tale delega è stata attuata dal D.Lgs. n. 119
del 2011, in particolare dall’art. 6.
7.11. il D.Lgs. n. 119
del 2011, art. 6, comma 1,
lett. a), ha aggiunto un periodo al comma 3 della L. n. 104 del
1992, art. 33 relativo
alla disciplina della particolare fattispecie del cumulo dei permessi mensili
retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più
persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate
situazioni ivi elencate.
7.12 Da ultimo la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della L. n. 104 del
1992, art. 33, comma 3,
nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione
– tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per
l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa
al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
7.13. In tale pronuncia è stato rimarcato che il
permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, è espressione dello
Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni
e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente
disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che,
come quello del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151
del 2001, art. 42, comma 5,
è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione
di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di
solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.
Nell’interpretazione del giudice delle leggi, la
tutela della salute psicofisica del disabile, costituente la finalità
perseguita dalla L. n. 104 del
1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi
di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e
nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. sentenze
n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).
8. Nel novero di tali interventi si iscrive il diritto
al permesso mensile retribuito in questione.
8.1. Infatti, alla luce dei suoi presupposti e delle
vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ratio legis dell’istituto in
esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave
in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto
all’assistenza da parte dell’handicappato solo una situazione nella quale il
livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto
similare.
8.2. Solo strutture di tal genere, infatti, possono
farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle
esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l’intervento, a
detti fini, dei familiari.
8.3. L’interesse primario cui è preposta la norma in
questione è, del resto, quello di “assicurare in via prioritaria la
continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in
ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio
dell’assistito” (v. Coste Cost. sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007
citate). Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in
situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità
fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dalla L. n. 104 del
1992, art. 3, comma 3.
8.4. L’istituto del permesso mensile retribuito è
allora in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite
dalla L. n. 104 del
1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica
della persona portatrice di handicap, diritto fondamentale dell’individuo ai
sensi dell’art. 32
Cost., rientrante tra i diritti inviolabili che la Repubblica
riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità (art. 2
Cost.).
8.5. Pur con i vari interventi legislativi è stata
tenuta ferma la condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a
tempo pieno (cioè per tutte le 24 ore del giorno).
8.6. Tale condizione non può che intendersi riferita
al ricovero presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che
assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Solo se la struttura ospitante sia in grado di
garantire un’assistenza sanitaria in modo continuo e così di assicurare al
portatore di handicap grave tutte le prestazioni sanitarie necessarie e
richieste dal suo status si rende superfluo, o comunque non indispensabile,
l’intervento del familiare, venendo così meno l’esigenza di assistenza posta a
base dei permessi.
8.7. Se, invece, la struttura non sia in grado di
assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di
fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in
coerenza con la ratio dell’istituto dei permessi (secondo gli stessi arresti
della giurisprudenza costituzionale sopra citati in ordine all’irrilevanza di
forme di assistenza non continuativa) che è quella di consentire l’assistenza
della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui
questa non lo sia.
Solo tale esigenza giustifica il sacrificio imposto al
datore di lavoro, in adempimento ad obblighi ispirati al dovere costituzionale
di solidarietà.
8.8. Peraltro, come evidenziato, le disposizioni di
cui alla L. n. 104 del
1992 sono state oggetto di importanti modifiche aggiuntive ed
innovative, introdotte con le L. n. 423 del
1993 e L. n. 53 del
2000, complessivamente caratterizzate da una implementazione del
diritto all’assistenza del disabile: tale criterio, che costituisce la ratio
legis deve presiedere all’attività di interpretazione della disposizione di che
trattasi al fine di assicurare coerenza al sistema e compatibilità con i
principi costituzionali, anche ex art. 3 Cost..
8.9. Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire
dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture
residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di
riposo perchè queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre
non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere
presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che
assicurano assistenza sanitaria continuativa.
8.10. L’interpretazione qui privilegiata è stata, del
resto, fatta propria da questa Corte di cassazione in sede penale (v. Cass. 21
febbraio 2013, n. 8435), laddove, in relazione alla posizione di un pubblico
dipendente che rispondeva del reato di falso per aver attestato, appunto
falsamente, che la madre ed il padre non erano ricoverati a tempo pieno presso
una casa di riposo, richiamando anche le Circolari dell’INPS del 3 dicembre
2010, n. 155 e del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, ha
ritenuto che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere
ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private,
che assicurano assistenza sanitaria continuativà e dunque la natura sanitaria
del ricovero.
8.11. Proprio sulla scorta di tale precedente, il
Tribunale di Torino, investito in sede penale a seguito della denuncia
presentata nei confronti del R. dalla ASL in relazione al reato di cui all’art. 483
c.p., con decreto del
23/8/2017, su conforme richiesta del P.M., ha disposto l’archiviazione
ritenendo che il termine ricovero di cui alla L. n. 104 del
1992, art. 33 fosse
riferibile al solo ricovero in strutture di tipo sanitario (si vedano gli atti
richiamati dal ricorrente ed allegati al ricorso per cassazione).
9. Tale essendo il quadro normativo di riferimento va
ritenuto che la Corte territoriale chiamata a valutare la sussistenza o meno di
una falsa dichiarazione con riferimento alla compilazione da parte del R. del
modulo predisposto dall’Azienda (compilazione da effettuarsi nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà D.P.R. n. 445
del 2000, ex art. 76), avente ad oggetto i requisiti per fruire dei
benefici L. n. 104 del
1992, ex art. 33 ed in particolare alla parte in cui era indicata
quale condizione negativa (da barrare da parte dell’interessato) la frase ‘non
ricoverata a tempo pieno presso alcuna strutturà, avrebbe dovuto tener conto
delle finalità per le quali la dichiarazione stessa doveva essere resa e quindi
affermarne od escluderne la veridicità non in relazione ad una nozione atecnica
di ricovero bensì con riferimento alle condizioni richieste per la fruizione
del beneficio e cioè ad un ricovero presso una struttura in grado di garantire
un’assistenza sanitaria in modo continuo al portatore di handicap grave.
9.1. Così avrebbe dovuto valutare se l’aver apposto
una crocetta in corrispondenza di tale frase in presenza di un ricovero della
persona da assistere (madre del R.) presso la (OMISSIS) a partire dal 20 luglio
2012, e cioè presso una struttura che non offriva, come è pacifico, assistenza
sanitaria, potesse integrare, alla luce della ratio della disposizione agevolativa
come sopra ricostruita, una dichiarazione mendace.
9.2. E pur vero che un fatto non costituente illecito
penale può essere, ciò nondimeno, rilevante ai fini disciplinari, tuttavia è
sempre necessario che sussistano profili di antigiuridicità che vanno
specificamente indicati, anche alla luce delle previsioni del codice
disciplinare.
9.3. Nella specie, peraltro, nessuna contestazione
sull’utilizzo indebito dei permessi era stata formulata al dipendente essendo
stata posta a base del provvedimento espulsivo solo la circostanza di aver il
R. reso dichiarazioni mendaci, ritenuta rilevante sotto il profilo
dell’affidabilità morale e professionale del predetto e come tale inficiante in
modo irreversibile il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere
tra lavoratore e datore di lavoro (si vedano il contenuto della contestazione e
del conseguente provvedimento di licenziamento come riportati in sede di
ricorso per cassazione nonchè il passaggio della stessa memoria difensiva della
ASL del 7/12/2016, pure riportato in ricorso, nel quale è evidenziato che
“la valutazione che l’UPD è stato chiamato ad effettuare…. non ha
riguardato…. la verifica della sussistenza o meno dei presupposti necessari
al sig. R. per continuare a beneficiare dei permessi della L. n. 104 del
1992…”).
9.4. Anche il profilo dell’affidabilità morale e
professionale andava, perciò, considerato tenendo conto dell’ambito definito
della contestazione limitata alla dichiarazione asseritamente mendace
rilasciata dal R..
10. Da tanto consegue che, assorbiti gli ulteriori
rilievi, il ricorso, conformemente alle conclusioni del P.G., deve essere
accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino che procederà
ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati e provvederà anche
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M. motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18
giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in