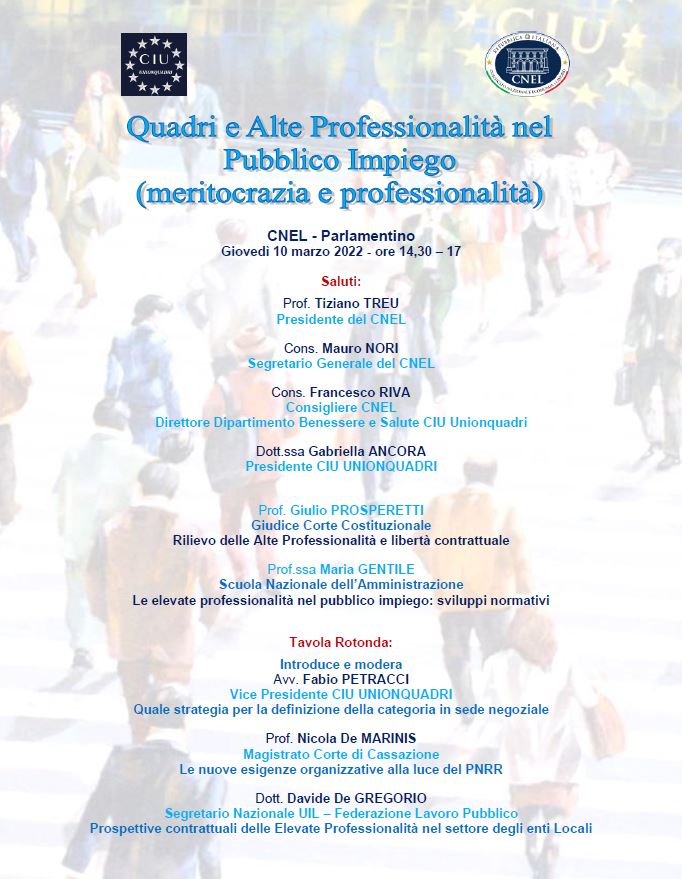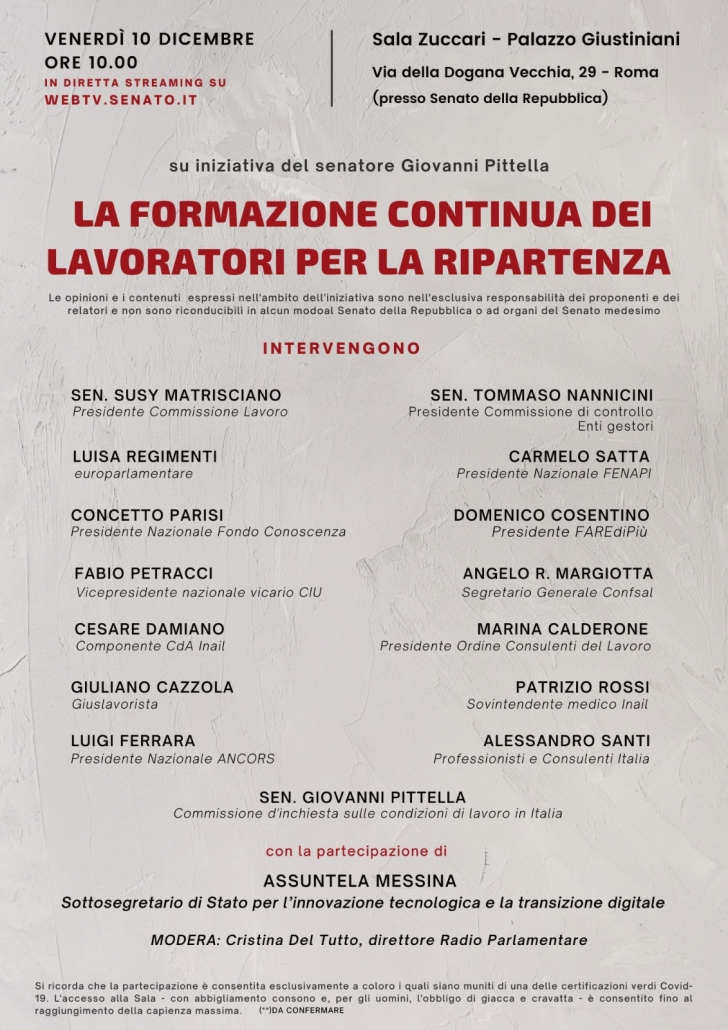Il disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale
In data 13 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha approvato l’IA Act, di cui è attesa la pubblicazione. Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il disegno di legge italiano non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento europeo è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).
Le norme intervengono in cinque ambiti:
- la strategia nazionale;
- le autorità nazionali;
- le azioni di promozione;
- la tutela del diritto di autore;
- le sanzioni penali.
Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori.
La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
Vengono altresì specificati i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve infatti pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.